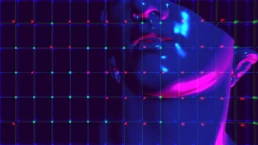Ethereum (ETH) è una criptovaluta, nata successivamente a Bitcoin, con cui condivide la caratteristica della decentralizzazione basata su tecnologia blockchain. Differentemente dalla blockchain di Bitcoin, ed in aggiunta a questa, la blockchain di Ethereum, oltre ad assicurare l’emissione e lo scambio di ETH, è caratterizzata dalla presenza di un computer virtuale decentralizzato, detto Ethereum Virtual Machine (EVM), che permea questa blockchain e consente l’esecuzione di programmi, detti Smart contract.
A dispetto della denominazione, essi non hanno nulla a che vedere con quello che nel mondo del diritto è definito “contratto”, ossia l’accordo di una o più parti destinato ad avere forza di legge per regolare un rapporto giuridico patrimoniale. Gli smart contract sono, invece, sequenze di istruzioni informatiche (programmi) destinati ad essere eseguiti dalla Virtual Machine (EVM) e, rispetto ai programmi informatici che tutti usiamo quotidianamente, la loro caratteristica principale sta nel fatto che il loro controllo e la loro esecuzione è (in qualche misura, anche se non necessariamente in modo completo) sottratta al controllo del suo autore, in quanto le line di codice sono memorizzate sulla blockchain, quindi immodificabili.
L’idea di base dello Smart contract (di qui, probabilmente, l’impropria assonanza con un “contratto”), è che l’esecuzione di una determinata operazione (si usa, come esempio, il pagamento di un risarcimento del danno da parte di un’assicurazione) non sia revocabile o arrestabile da parte del soggetto che si è obbligato ad eseguirla.
Anche la disciplina normativa italiana riflette questo equivoco di fondo. La definizione contenuta nell’art. 8ter del DL 135/2016 parla di “programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse”. Da un lato, infatti, si parla di “vincolo automatico” tra le parti (cosa evidentemente impossibile nel nostro ordinamento giuridico, oltre che per il senso comune); dall’altro lato, e nella stessa frase, si precisa però che gli effetti sono “predefiniti dalle stesse”, tornando, così, nell’alveo del contratto definito dal codice civile (art. 1321).
news
Carlo Cicala: Le Criptovalute, tra rischi e opportunità.
Intervento nell’ambito delle “Giornate di studio in materia di Cybersecurity” organizzate dal Consiglio Nazionale Forense. L’intervento di Carlo…
Carlo Cicala. Criptoattività: definizioni e tipologie
Intervento di Carlo Cicala all’incontro di studio della Scuola Superiore della Magistratura: “Il fenomeno delle criptovalute e il suo inquadramento…
Diritto e Blockchain, Carlo Cicala: La natura giuridica dei token
(Teleborsa) - Si parla di criptovalute come mezzo alternativo ai pagamenti tradizionali o come strumento speculativo. Ma dalla loro infrastruttura…
Diritto e Blockchain, Cicala: “Bitcoin e le altre cripto-attività, come le vede il diritto italiano?”
Il fenomeno delle criptovalute ha suscitato reazioni di diversa natura. Da un lato i recenti crack che hanno caratterizzato questo mondo hanno…